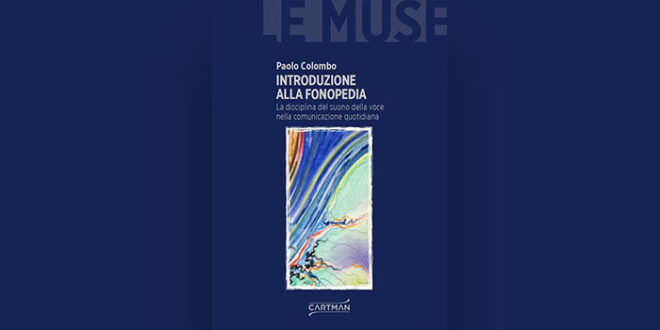Ci stiamo avviando al periodo più caldo della campagna elettorale e assisteremo a dibattiti sempre più numerosi e accesi.
È possibile comprendere se esiste corrispondenza tra le parole che ascolteremo, le reali intenzioni e gli stati d’animo di chi parla?
Abbiamo intervistato Paolo Colombo, musicista e musicologo, autore del volume “ Introduzione alla fonopedia” (Ed. Cartman 2021, music.paoloc@gmail.com), nuova disciplina da lui stesso ideata che cerca di varcare la soglia della comunicazione (e dunque delle relazioni umane) attraverso questo innovativo e approfondito studio del linguaggio.
Ci suggerisce qualche semplice strumento interpretativo fonopedico in vista dei dibattiti della campagna elettorale?
Premessa la complessità dell’analisi fonopedica, qualche piccola indicazione si può certo dare.
Questi consigli andrebbero utilizzati non tanto durante l’ascolto di dichiarazioni individuali, comizi e interviste, quanto nei dibattiti in cui possono emergere elementi imprevisti tali da far apprezzare l’autentica reazione emotiva e intenzionale.
Primo strumento: verifica della frequenza della cosiddetta “tonìa conclusiva”, ovvero l’abbassamento dell’intonazione per sancire la chiusura di una concetto, di una frase, coincidente con il “punto”.
Ci sono persone che tendono a non concludere mai l’enunciato e che mantengono un’intonazione di registro medio, evitando di terminare un concetto e passare all’altro. Viceversa esistono coloro che, con frequenza abbastanza regolare, lo chiudono, dimostrando quantomeno idee strutturate.
Secondo strumento: anche le pause vuote, ovvero i silenzi, hanno un significato in base alla collocazione, alla funzione e alla durata (che la fonopedia non calcola in secondi ma con una unità di misura specifica). Si valuti quindi se chi parla si ferma prevalentemente in corrispondenza della punteggiatura (pausa sintattica), dell’incertezza (pausa d’esitazione), dell’enfasi su ciò che si è detto o sta per essere detto (pausa di valore), della mancanza di fiato (pausa di respirazione).
Terzo strumento: l’esitazione si manifesta anche con le cosiddette “pause piene”, ovvero il prolungamento dell’ultima vocale delle parole (ad esempio: domaniii, forseee) o l’inserimento di vocali prolungate (ad esempio: eee) con l’obiettivo di “coprire” il vuoto creato dalla necessità di pensare a cosa dire. Si cerchi di capire perché si voglia “nascondere” il silenzio del pensiero…
Questi sono solo tre semplicissimi strumenti fra i tanti che la fonopedia mette a disposizione per scoprire cosa si cela “dietro alla parola”.
Come si può definire la fonopedia?
È la disciplina interpretativa/educativa del suono della voce, la cui scientificità si fonda su unità di misura specifiche e una forma di scrittura (il “foneticon”) che finalmente consente di visualizzare intuitivamente l’intonazione della voce, quasi in una sorta di “partitura”.
Partitura che, proprio come accade in musica, può essere letta alla luce della retorica musicale per individuare i significati dell’intonazione.
La musica risolve in questo modo il problema linguistico di come scrivere e analizzare il suono della voce parlata. Ma solo così si può studiare seriamente il suono della voce nella comunicazione quotidiana.
Qual è la differenza tra parola e suono della voce?
La parola esprime un “range” di significati che solo il suono della voce è in grado di disambiguare. Un esempio? Se pronuncio la parola “bravo” non è affatto detto che voglia fare un complimento; dipende, appunto, dall’intonazione che può persino contraddire il concetto, con ironia, sarcasmo o fastidio. Ecco perché è fondamentale fare un controllo incrociato tra il significato della parola e quello del suono della voce per verificare la loro eventuale incongruenza.
Questa incongruenza è sinonimo di bugia?
L’incongruenza c’è quando si dicono cose di cui non si è totalmente convinti, ma i motivi sono tanti: si va dalla semplice cortesia (quando, per non ferirlo, non si dice a un amico che non ci piace la sua nuova auto) sino alla mistificazione più colpevole (come la falsa testimonianza).
All’interno dell’incongruenza, è con la parola che “si mente”, mentre il suono della voce è sempre sincera manifestazione di ciò che proviamo e l’eventuale tentativo di modificarlo o mascherarlo lo rende ancora più palesemente incongruente.
Basare la comunicazione sulla parola, senza considerare i significati dell’intonazione, può determinare pericolosi fraintendimenti, particolarmente dannosi in attività delicate come quelle pedagogiche, terapeutiche, investigative e diplomatiche.
Gli strumenti fonopedici che precisione hanno nel rilevare il significato del suono?
La fonopedia è la prima disciplina in grado di misurare, visualizzare e individuare il significato del suono anche più breve, come un’esclamazione di tre decimi di secondo: questa è la più evidente differenza con tutti gli altri approcci e metodi relativi all’intonazione.
Ad esempio, quanti modi esistono per intonare un “sì” (affermazione), ognuno con diverse ma fondamentali sfumature? La fonopedia, con il “foneticon”, è in grado di visualizzarli tutti e rilevarne il significato più profondo.
La fonopedia può anche insegnare a intonare efficacemente?
Certo, ma si ricordi che Alfred Tomatis affermava che si possono emettere solo i suoni che si è in grado di percepire. Pertanto chi volesse seguire un percorso pedagogico fonopedico per l’intonazione deve anzitutto esercitare l’ascolto per cogliere quelle microespressioni della voce che poi dovrà emettere consapevolmente. È impossibile accordarsi senza avere un orecchio ben allenato, così come non può cantare chi non riconosce la differenza tra le note.
Intervista di Massimo Vernacotola
Titolo: Introduzione alla fonopedia
Autore: Paolo Colombo
Ed. CARTMAN
ISBN13: 9788889671818
 Radio Web Italia Radio On-Line, Notizie Musicali, Cinema, Spettacolo e tanto altro
Radio Web Italia Radio On-Line, Notizie Musicali, Cinema, Spettacolo e tanto altro