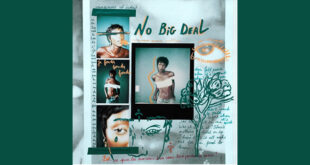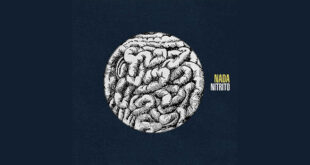La destinazione alla pubblica fruizione di beni culturali di rilevante valore storico-artistico nella città di Bologna si amplia con un importante tassello. Grazie ad un accordo siglato tra Compagnia dei Lombardi e Istituzione Bologna Musei, un prezioso nucleo di otto tavole di epoca medievale appartenenti a due perduti polittici di Simone di Filippo detto ‘dei Crocifissi’ e di Giovanni di Pietro Falloppi detto da Modena, di proprietà dell’antica compagnia d’armi felsinea, viene concesso in comodato d’uso gratuito ai Musei Civici d’Arte Antica. La durata del contratto di comodato è fissata in 8 anni, rinnovabile.
Per assicurare adeguate condizioni ambientali sotto il profilo della conservazione, oltre che di una più agevole lettura nel contesto del tessuto storico-culturale in cui sono state realizzate, come sede più idonea per il trasferimento e l’esposizione delle opere – capolavori della pittura gotica e tardogotica raffiguranti santi e sante verso i quali era viva la devozione cittadina – sono state individuate le Collezioni Comunali d’Arte, il museo collocato al secondo piano di Palazzo d’Accursio dove è conservata un’importante raccolta di opere del XIV secolo e XV secolo.
Per presentare alla città questa importante azione congiunta di tutela e valorizzazione di un patrimonio per secoli precluso a chiunque non fosse aggregato alla Compagnia, si è ritenuto di promuovere un progetto espositivo che consentisse al pubblico di ripercorrere le vicende legate alle origini della Compagnia dei Lombardi – una delle antiche società d’armi sorte in età comunale a Bologna, l’unica ancora oggi attiva nella sede attigua al complesso monumentale della Basilica di Santo Stefano – e alla formazione di una prestigiosa, seppure quantitativamente esigua, collezione di opere d’arte.
Nella mostra Un passato presente. L’Antica Compagnia dei Lombardi in Bologna, a cura di Massimo Medica e Silvia Battistini e allestita dal 12 ottobre 2019 al 9 febbraio 2020 in Sala Urbana, è così possibile ammirare in anteprima le opere generosamente offerte in comodato, affiancate da una selezione di documenti storici provenienti dall’Archivio della Compagnia e dall’Archivio di Stato di Bologna, che illustrano le vicende e ritualità di una storia che la tradizione vuole iniziata nel 1170 con la fondazione di un’alleanza di mutuo soccorso tra esuli trasferitisi dalla Lombardia a causa delle lotte tra le fazioni Guelfe e Ghibelline e delle barbarie di Federico I Barbarossa. Al termine dell’esposizione, le opere resteranno visibili nella Sala 6 del percorso espositivo del museo, dove sono testimoniati momenti della cultura figurativa del Cinquecento, non solo bolognese.
In occasione della mostra, Silvana Editoriale pubblica il catalogo contenente saggi di Mario Fanti, Romolo Dodi, Massimo Medica, Giacomo Alberto Calogero, Ilaria Negretti e schede a cura di Ilaria Negretti, Silvia Battistini, Gianluca del Monaco, Mark Gregory D’Apuzzo.

Calendario visite guidate Le visite guidate sono gratuite previo pagamento biglietto di ingresso al museo.
domenica 13 ottobre 2019 h 10.30
sabato 26 ottobre 2019 h 11.00
sabato 9 novembre 2019 h 16.30
sabato 23 novembre 2019 h 10.30
sabato 7 dicembre 2019 h 16.30
sabato 4 gennaio 2020 h 16.30
domenica 26 gennaio 2020 h 16.30
domenica 9 febbraio 2020 h 10.30
Cenni storici sulla raccolta d’arte della Compagnia dei Lombardi in Bologna La prestigiosa raccolta d’arte appartenente alla Compagnia dei Lombardi è costituita da dipinti che furono probabilmente acquisiti nel tempo grazie alle facoltose donazione dei propri membri. Il nucleo medievale è composto da otto tavole appartenenti a due perduti polittici: il più antico è opera di Simone di Filippo detto ‘dei Crocifissi’ mentre il secondo è stato realizzato dal campione del tardogotico bolognese, Giovanni da Modena. Nel 1723, secondo la documentazione della Compagnia dei Lombardi, nella sala in Santo Stefano a Bologna erano ricordati «10 santi dipinti in altrettanti pezzi di asse disgiunti»: non essendo citati nella precedente descrizione del 1717, appare probabile che la loro acquisizione avvenisse proprio tra quelle due date, mentre i due scomparti in più presenti nelle fonti furono successivamente alienati.
Le quattro tavole dipinte da Simone di Filippo con San Giovanni Battista, San Michele Arcangelo, Santa Caterina d’Alessandra e Santa Maria Maddalena, costituivano in origine gli scomparti laterali di un unico polittico. Nella parte superiore delle opere è tuttora visibile la traccia della cornice polilobata e le aureole dei santi presentano la stessa decorazione. Se da un punto di vista stilistico la critica si è trovata concorde nell’attribuirli all’estrema fase creativa del pittore bolognese, databili perciò agli anni novanta del Trecento, più problematica è l’individuazione della loro provenienza originale: l’ipotesi più plausibile le vorrebbe individuare quali parte di un polittico con al centro l’Incoronazione della Vergine, che, firmato da Simone, venne descritto nel 1686 nella scomparsa chiesa di San Michele del Mercato dal canonico Malvasia.
Le altre quattro tavole con San Giacomo Maggiore, San Pietro, San Nicola da Tolentino e San Francesco, attribuite a Giovanni, sono state ricollegate ai due scomparti di medesima fattura con Sant’Antonio Abate e San Domenico, oggi conservati presso la Pinacoteca Nazionale di Ferrara. I sei manufatti provenivano da un polittico smembrato, verosimilmente commissionato per la chiesa di San Giacomo Maggiore a Bologna, vista la presenza di diversi santi cari all’ordine agostiniano. Per la datazione è possibile considerare come terminus post quem la canonizzazione di Nicola da Tolentino, avvenuta nel 1446 per volontà di papa Eugenio IV, e confermata dallo stile tardo del maestro, dove le acutezze naturalistiche dell’ambientazione, ricorrente in tutte le tavole, testimoniano lo stretto legame con la cultura tardogotica padana.
Alla prima metà degli anni cinquanta del Quattrocento risale la tela rinascimentale del giovane pittore Tommaso Garelli, conservata nella sede della Compagnia, dove venne collocata sopra al banco ligneo degli Uffiziali al tempo della ristrutturazione voluta da Benedetto XIV dopo la sua elezione a Massaro (1753-1754). L’opera, raffigurante la Vergine in trono col Bambino tra i santi Nicola di Bari, Pietro, Michele Arcangelo e Petronio, è corredata da un’iscrizione celebrativa della Compagnia e dei suoi ufficiali datata 1466, che, in seguito a una recente e accurata analisi, è stata ritenuta non coeva alla pittura. Un’ipotesi ben supportata anche dallo stile dell’artista, che da un lato è ancora debitore alla tradizione del vecchio Giovanni da Modena, dall’altro risente già degli esiti di più salda monumentalità e sfarzo decorativo dei Vivarini.
Elenco opere e documenti in mostra
Simone di Filippo, detto ‘dei Crocifissi’ (Bologna, doc. dal 1354, morto nel 1399) San Giovanni Battista, ca. 1395-1399 tempera e oro su tavola, cm 57×25
Simone di Filippo, detto ‘dei Crocifissi’ San Michele Arcangelo, ca. 1395-1399 tempera e oro su tavola, cm 57×25
Simone di Filippo, detto ‘dei Crocifissi’ Santa Caterina d’Alessandria, ca. 1395-1399 tempera e oro su tavola, cm 57×25
Simone di Filippo, detto ‘dei Crocifissi’ Santa Maria Maddalena, ca. 1395-1399 tempera e oro su tavola, cm 57×25
Giovanni di Pietro Falloppi, detto da Modena (doc. dal 1409 – Modena 1454-1455) San Giacomo Maggiore, ca. 1450 tempera e oro su tavola, cm 80×29
Giovanni di Pietro Falloppi, detto da Modena San Pietro, ca. 1450 tempera e oro su tavola, cm 80×29
Giovanni di Pietro Falloppi, detto da Modena San Nicola da Tolentino, ca. 1450 tempera e oro su tavola, cm 80×29
Giovanni di Pietro Falloppi, detto da Modena San Francesco, ca. 1450 tempera e oro su tavola, cm 80×29
Elezione dei ministrali delle Compagnie d’armi, 1313 Codice membranaceo Bologna, Archivio di Stato
Lando di Antonio (doc. prima metà del XIV sec.) Matricola della Compagnia dei Lombardi, 1334 Codice membranaceo; pergamena e tempera Bologna, Compagnia dei Lombardi
Scipione Cavalletto (?) (doc. tra 1516 e 1528) Matricola della Compagnia dei Lombardi, 1524 Codice membranaceo; pergamena e tempera Bologna, Compagnia dei Lombardi
Giuseppe Maria Crespi (Bologna, 14 marzo 1665 – 16 luglio 1747) Ritratto del cardinale Prospero Lambertini, 1739 olio su tela Bologna, Collezioni Comunali d’Arte
Matricola della Compagnia dei Lombardi, 1554 Codice membranaceo; pergamena e tempera Bologna, Compagnia dei Lombardi
Statuti della Compagnia dei Lombardi, 1480 Codice membranaceo; pergamena e tempera Bologna, Compagnia dei Lombardi
Lettera di papa Benedetto XIV alla Compagnia dei Lombardi, 15 gennaio 1755 carta e inchiostro Bologna, Compagnia dei Lombardi
Relazione nella quale si ipotizza l’aggregazione alla Compagnia dei Lombardi della famiglia di Papa Pio VI (Giovanni Angelo Braschi), ultimo quarto del XVIII secolo carta e inchiostro Bologna, Compagnia dei Lombardi
Anonimo del XVIII secolo Sonetto in ‘lingua bolognese’ dedicato alla Compagnia dei Lombardi carta e inchiostro Bologna, Compagnia dei Lombardi
Elenco dei militi della Compagnia, 9 febbraio 1794 Fascicolo; carta e inchiostro Bologna, Compagnia dei Lombardi

Presentazioni istituzionali Questa esposizione rinsalda una collaborazione già sperimentata e intensa tra l’antica Compagnia dei Lombardi e l’Istituzione Bologna Musei, che negli anni si è concretizzata attraverso varie ed importanti iniziative organizzate con i Musei Civici d’Arte Antica. Nella mostra, ospitata all’interno delle Collezioni Comunali d’Arte, sono raccolte alcune delle opere precedentemente custodite nella sede dell’antica Compagnia dei Lombardi. In questa occasione c’è un significativo elemento di novità rispetto a ciò che è accaduto nelle esposizioni precedenti. Infatti l’antica e prestigiosa istituzione bolognese ha manifestato la volontà di depositare alcune tavole dipinte di epoca medievale presso i Musei Civici di Arte Antica. Consapevoli della importanza di questo gesto si è ritenuto che le Collezioni Comunali d’Arte, ricche di un’importante raccolta di opere del XIV e XV secolo, fossero la sede più adatta per esporre anche queste tavole, provenienti da due differenti polittici dipinti da esponenti di spicco della pittura locale: Simone dei Crocifissi e Giovanni da Modena. Prima di collocare i dipinti nel percorso espositivo permanente del museo, si è voluto realizzare questa mostra che racconta la storia ed il ruolo sociale e culturale della Compagnia da cui provengono, in modo che fosse possibile per il pubblico comprendere meglio l’importanza e l’unicità dell’evento. La determinazione degli aggregati alle cinquanta famiglie aggregate alla Compagnia, del Consiglio degli Uffiziali e del Massaro ha reso possibile questo progetto, articolato quindi in due momenti: una prima presentazione dell’attività dei ‘Lombardi’ dalla costituzione fino ai tempi più recenti, grazie ad una ricca serie di documenti societari e lettere di grande interesse; la definizione di uno spazio nella sala 6 delle Collezioni Comunali d’Arte in cui, al termine della mostra, verranno esposte le opere concesse in deposito, corredate di pannelli che illustreranno la storia della Compagnia dei Lombardi. Anche questa mostra rientra pienamente fra i principali obiettivi dell’Istituzione Bologna Musei, che è quello di valorizzare il proprio patrimonio artistico facendolo conoscere ad un pubblico sempre più vasto. Per fare questo vengono abitualmente realizzate diverse attività, quali conferenze, visite guidate, presentazioni di libri e concerti, ma senza dubbio sono fondamentali le esposizioni che approfondiscono specifici argomenti. Queste iniziative sono un’occasione per rendere ancora più evidente lo stretto legame delle collezioni dei musei con la città, la sua storia e la sua tradizione culturale. Perché ciò sia ancora più efficace, è importante, come in questo caso, dialogare e coinvolgere altre istituzioni cittadine.
Roberto Grandi Presidente Istituzione Bologna Musei
L’antichissima Compagnia Militare dei Lombardi in Bologna si presenta con questa mostra per ricordare il suo passato presente di oltre otto secoli nella nostra città. Le compagnie d’armi, delle quali La Compagnia dei Lombardi è l’unica sopravvissuta, sorte nella seconda metà del XII secolo, costituirono per tutto il secolo seguente il braccio armato delle nascenti strutture comunali fino a quando, nella prima metà del Trecento, esse iniziarono la loro parabola discendente trasformandosi in sodalizio familiare. Certo è che nelle alterne vicende storiche di Bologna la Compagnia fu ritenuta importante anche nel periodo della signoria Bentivoglio e l’appartenenza ad essa era, ed è rimasta, particolarmente ambita e gelosamente conservata nel tempo dalle famiglie via via aggregate. In questi ultimi anni maturava tra i membri della Compagnia l’idea di costruire un progetto per valorizzare il proprio esiguo, ma prestigioso, patrimonio artistico esponendolo per qualche tempo in una struttura museale che potesse permetterne la visione ad un numero crescente di pubblico e potesse nel contempo diffondere la conoscenza di una tra le più antiche istituzioni bolognesi. Si trattava delle preziose tavole di Simone dei Crocifissi e di Giovanni da Modena custodite nella casetta, sita nel complesso monumentale di Santo Stefano, che ancora oggi è sede della Compagnia e piccolo scrigno di memorie felsinee dove furono ospitati anche pittori tra i quali Angelo Crescimbeni, Ubaldo Gandolfi e Ivan Akimow. In seno alla Compagnia, e con autorevoli personalità, si discussero nel tempo alcuni progetti per individuare il luogo ideale che potesse accogliere quelle opere, sia dal punto di vista ambientale che della sicurezza, un luogo dove già viveva la storia della città e dove potesse vivere, tra la gente, la storia della Antichissima Compagnia Militare dei Lombardi in Bologna. Con questo obbiettivo, a distanza di tanti secoli, due delle più antiche istituzioni bolognesi ora si incontrano nuovamente; ciò avviene nientemeno che in Palazzo d’Accursio, storica sede del potere e dell’amministrazione cittadina, nelle cui sale da tempo si conservano le collezioni d’arte del Comune stesso. L’esposizione, concordata con Massimo Medica, è significativamente preceduta da una mostra dal titolo Un passato presente. L’antica Compagnia dei Lombardi in Bologna che permette di ammirare in anteprima, nella prestigiosa Sala Urbana, le opere offerte in comodato insieme ad alcuni preziosissimi documenti. Un particolare riconoscimento va certamente al vertice delle istituzioni museali cittadine, al Presidente dell’Istituzione Bologna, Roberto Grandi, al direttore dell’Istituzione Bologna Musei Maurizio Ferretti, segnatamente a Massimo Medica, responsabile dei Musei Civici d’Arte Antica, e alla dottoressa Silvia Battistini, curatrice delle Collezioni Comunali d’Arte, che con noi hanno amabilmente interloquito per la realizzazione del progetto, senza dimenticare però il primo ideatore, il compianto Gonfaloniere ed amico Tonino Rubbi, e tutti i “militi” delle cinquanta famiglie aggregate all’antichissima Compagnia che hanno voluto manifestare con generosa partecipazione la loro affectio societatis vissuta nel solco della tradizione e al passo con i tempi.
Antica Compagnia dei Lombardi
Giuliano Malvezzi Campeggi Romolo Dodi Filippo Sassoli de’ Bianchi Cancelliere Massaro Depositario
Collezioni Comunali d’Arte Il secondo piano del Palazzo Comunale di Bologna ospita, all’interno delle sale che un tempo erano adibite a residenza del Cardinale Legato, le Collezioni Comunali d’Arte, istituite nel 1936. Il museo è allestito negli ambienti ornati con fregi e soffitti dipinti dal Cinquecento al Settecento, recuperati in seguito all’ingente campagna di restauri promossa nel 1934 sotto la direzione di Guido Zucchini. Le opere con cui sono stati arredati provengono da un variegato patrimonio – costituitosi grazie a molteplici donazioni di dipinti, mobili, arredi e suppellettili, giunti al Comune di Bologna nel corso dell’Ottocento e nel primo Novecento -, che andò ad arricchire l’antico corpus di capolavori appartenuti alle magistrature cittadine. In particolare si segnalano quelli provenienti da due importanti collezioni d’artista (Pelagio Palagi e Cincinnato Baruzzi), nonché quelli derivati da un collezionismo versato anche nel campo delle arti applicate e dell’arredo (eredità Pepoli e Rusconi). Il ricco patrimonio artistico custodito dalle Collezioni Comunali d’Arte spazia dal Duecento agli inizi del Novecento: croci scolpite, tavole dipinte di Vitale da Bologna, Jacopo di Paolo (Annunciazione), Luca Signorelli (Testa di Maddalena), Francesco Francia (Crocifissione), in origine custodite nella sezione medievale dell’allora Museo Civico; inoltre, importanti dipinti di ambito bolognese-emiliano del primo Cinquecento (Amico Aspertini, il Tamaroccio) e del secondo (Bartolomeo Passerotti e Ludovico Carracci), fino a una nutrita serie di opere del XVII secolo di scuola emiliana (Alessandro Tiarini, Guido Cagnacci, Michele Desubleo, Francesco Gessi) e di altre scuole fra cui uno straordinario Ritratto di Gonfaloniere, eseguito nel 1622 dall’illustre pittrice Artemisia Gentileschi. Sotto la volta affrescata della Galleria Vidoniana, commissionata nel 1665 dal Cardinale Legato Pietro Vidoni, è visibile una delle raccolte più importanti all’origine del museo: diciotto tele eseguite fra il 1713 e il 1723 circa da Donato Creti e donate dal committente Marcantonio Collina Sbaraglia al Senato bolognese nel 1744. Dalla monumentale galleria si continua il percorso nell’appartamento del Legato, raggiungendo l’ala Rusconi, composta da cinque piccole sale riservate alla vita privata, arredate con mobili, dipinti e suppellettili provenienti appunto dalla antica famiglia Rusconi dove si rivive la raffinata atmosfera delle dimore private del XVIII secolo. Il braccio del museo che le ospita termina in una magnifica sala “alla boschereccia”, dipinta alla fine del Settecento da Vincenzo Martinelli, così chiamata in quanto le pareti sono interamente decorate da dipinti murali, che riproducono un berceau di rampicanti oltre al quale si scorgono paesaggi di giardini e campagna. Una sezione è dedicata a Pelagio Palagi, artista di grande levatura nel campo della pittura, della progettazione di interni, dell’ornato e delle arti applicate fra Neoclassicismo e Romanticismo, ricordato a Bologna soprattutto come collezionista di ampia cultura e interessi multiformi. La sua raccolta storico-artistica contribuì ad arricchire in modo determinante il sistema museografico civico negli anni successivi all’Unità d’Italia. Infine due sale del museo sono dedicate all’arte dell’Ottocento e del primo Novecento. Tra i dipinti spiccano la celeberrima Ruth di Francesco Hayez, capolavoro della maturità dell’artista, il Ritratto di Cincinnato Baruzzi di Karl Brjullov, e Auxilium ex alto di Alfredo Savini, opera in cui si ritrova un “simbolismo religioso venato di suggestioni liberty”. Rappresentano la temperie culturale bolognese tra i due secoli anche la scultura in marmo di Giorgio Kienerk, L’anguilla, i progetti di ristrutturazione degli edifici storici cittadini, realizzati dagli architetti del Comitato per la Bologna Storico Artistica, e i merletti e ricami dell’Aemilia Ars, la società bolognese che in quegli anni rappresentò uno degli episodi più avanzati nel panorama italiano ed europeo di rinnovamento delle arti applicate. www.museibologna.it/arteantica
L’antichissima e nobilissima Compagnia Militare dei Lombardi in BolognaL’origine della Compagnia si fa tradizionalmente risalire al 1170, quando un gruppo di nobili lombardi si rifugiò a Bologna durante le lotte fra i Comuni e il Barbarossa. Gli studi più recenti hanno ricondotto però questa genesi al sorgere delle Compagnie d’Armi, che, nella prima metà del secolo XIII, costituirono il braccio armato del Populus, cioè della fazione popolare che stava prendendo il potere in città. Lo scopo primario del sodalizio fu la solidarietà tra i residenti felsinei provenienti dalla Lombardia, così come i toscani erano uniti nella simile Compagnia dei Toschi. Dalla matricola del 12721274 risultano 173 membri, provenienti dall’area dell’antica Langobardia maior, che da Modena si estendeva a gran parte del settentrione italiano. Nel Trecento, i ‘Lombardi’, allineati con i guelfi e divenuti ormai bolognesi, mantennero un ruolo importante, sia in relazione alle originarie funzioni solidaristiche sia ai vantaggi politico sociali assicurati ai suoi appartenenti. Perciò, al tramonto del Medioevo numerose famiglie magnatizie cittadine tentarono e riuscirono ad entrare nel prestigioso sodalizio. Nel 1494 Giovanni II Bentivoglio impose la fusione della Compagnia con la Confraternita di Santa Maria degli Angeli, che gestiva l’ospedale di San Procolo, detto dei Bastardini. Lo scopo era quello di instaurare un indiretto controllo sull’importante e facoltoso nosocomio, ma nel 1506, alla caduta della signoria, i ‘Lombardi’ si ricostituirono nell’antica sede del complesso della basilica di Santo Stefano. Durante i secoli della modernità la Compagnia andò accentuando il suo carattere aristocratico e furono aggregate molte famiglie senatorie di Bologna. Nonostante gli ottimi rapporti con il potere ecclesiastico, essa riuscì a preservare la sua natura di sodalizio familiare e laicale, di mera tradizione storica, senza alcuna connotazione confraternale. Questa fisionomia si rivelò essenziale, poiché nel 1797 permise ai ‘Lombardi’ di sottrarsi alle soppressioni napoleoniche. Tra i personaggi di rilievo che fecero parte della Compagnia vanno ricordati Benedetto XIV, Pier Jacopo Martelli, Pompeo Scipione Dolfi, Baldassarre Carrati, Ludovico Vittorio Savioli, Antonio Aldini, Luigi Salina, Gioacchino Napoleone e Carlo Pepoli, Giovanni Gozzadini e il cardinale Giacomo Biffi. Nell’Ottocento e nel Novecento, mentre le antiche famiglie si estinguevano, ne vennero aggregate di nuove, fino al numero stabilito di cinquanta. Oggi, dopo otto secoli, la Compagnia dei Lombardi si raduna annualmente nella sua storica sede per la nomina del Massaro e degli Uffiziali e per la tradizionale distribuzione ai soci, chiamati con l’antico appellativo di “militi”, delle focacce e delle candele, simbolo di continuità, di identità, di spirito civico e di tradizione familiare. www.compagniadeilombardi.it
Scheda tecnica
Titolo mostra: Un passato presente. L’Antica Compagnia dei Lombardi in Bologna
A cura di: Massimo Medica e Silvia Battistini
Periodo: 12 ottobre 2019 – 9 febbraio 2020
Inaugurazione: venerdì 11 ottobre 2019 h 17.30
Orari di apertura: da martedì a domenica h 10.00 – 18.30 chiuso lunedì non festivi, Natale, Capodanno
Biglietti: € 6 intero | € 3 ridotto | € 2 visitatori 18 ≤ 25 anni gratuito Card Musei Metropolitani Bologna e ogni prima domenica del mese
Informazioni: Collezioni Comunali d’Arte Palazzo d’Accursio, Piazza Maggiore 6 | 40121 Bologna tel. +39 051 2193998 | 051 2193631
www.museibologna.it/arteantica museiarteantica@comune.bologna.it Facebook Musei Civici d’Arte Antica
Istituzione Bologna Musei www.museibologna.it
[flagallery gid=2020] Radio Web Italia Radio On-Line, Notizie Musicali, Cinema, Spettacolo e tanto altro
Radio Web Italia Radio On-Line, Notizie Musicali, Cinema, Spettacolo e tanto altro